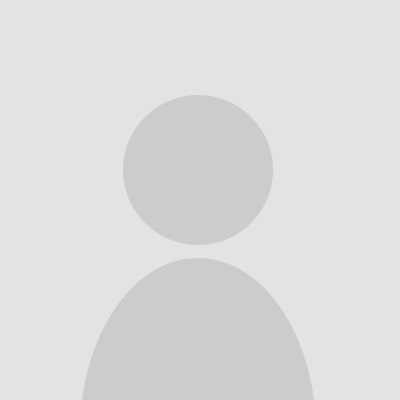>
>
 >
>
I testi dell’articolo
1)Mimì la bagnarota
2)Mia Martini e Bagnara
di Rino Cosentino
tratto da Calabriaora del 12 e 13 maggio 2010
Cresciuto, fin da bambino, a
Cosenza, per tanti anni mi ero
quasi dimenticato (o, per meglio
dire, l’avevo rimosso) di
essere nato a Bagnara. Lì, in
quel rione Milano, nei pressi
della stazione ferroviaria dove, quasi tre anni
dopo di me, a sola una manciata di metri dalla
casa di mia nonna, dove io venni alla luce,
appunto, nacque anche lei: sì, Domenica Bertè,
per tutti Mimì, in arte Mia Martini.
Il rione Milano era, allora, un grande villaggio
eterogeneo, con case molto modeste abitate
per lo più da famiglie di coffari, i lavoratori
delle famose sporte di Bagnara; e altre, invece,
più eleganti e signorili. Quella di mia nonna,
vedova di un commerciante di materiale da pesca
(Bagnara è stata, ed è tuttora, la grande patria
della caccia al pesce spada), ricordo che,
pur nella sua sobrietà, aveva un bel terrazzamento
tutto intorno e un giardinetto sul davanti
dove io trascorrevo la maggior parte delle
mie giornate.
La casa dove nacque Mimì (cosa che le biografie
su di lei non hanno mai ben specificato) era
un’ala della grande abitazione della famiglia di
don Saro Villari, direttore dell’ufficio
Telegrafico del paese, di cui i Bertè erano molto
amici. Anzi, più che amici, visto che a tenere a battesimo
Mimì fu proprio Giovanna, figlia
di don Saro (la famiglia
Villari, per meglio inquadrarla, era apparentata
ai più conosciuti, tutt’ora, illustri storici italiani
Lucio e Rosario Villari, anche loro originari
di Bagnara, ma della zona dell’Arangiara,
un po’ più a nord del paese).
Mimì nacque lì, dunque, nel settembre del
1947, un anno dopo il figlio di don Saro, Mimmo,
uno dei miei più cari amici d’infanzia. Io
sono del dicembre del ‘44, ma lei non diventò
mai mia amica perché, a sei anni, appena finita
la prima elementare, i miei genitori decisero
che io li raggiungessi a Cosenza, dove loro
già abitavano con i miei fratelli e le mie sorelle.
Con Mimmo Villari, invece, Mimì instaurò
una bella e duratura amicizia che si protrasse
nel tempo. Fin da piccola, da quando, con tutta
la famiglia, subendo il primo trauma della
sua vita, anche lei dovette lasciare Bagnara e
andare a vivere nei tanti posti
dove suo padre, insegnante di
latino e greco, si spostava per
il trasferimento di cattedra:
San Ginesio, Porto Recanati,
Ancona, nelle Marche, prima.
Poi, da solo, invece, nel 1959,
dopo la separazione con la
moglie (altro terribile colpo
per Mimì), a Busto Arsizio, in
provincia di Varese – un terzo
dolore glielo procurerà, infine,
la rottura del rapporto con Ivano
Fossati, per anni suo compagno
e collaboratore professionale.
Bagnara, dunque: il paese che
le era rimasto sempre nel cuore,
così come era accaduto anche
a me fino ai tempi dell’adolescenza,
quando (ormai
da cosentino, però) vi tornai,
nel 1962, a fare l’ultima mia
villeggiatura. E la incrociai appena
sulla rotonda del lido dei
fratelli De Forte: lei, giovanissima
cantante, ancora col nome
di Mimì Bertè, appunto; io,
ai primordi con la mia chitarra,
ingaggiato per quell’estate
dagli “Zenocar”, il complesso
più in voga allora del paese.
Chi ebbe la fortuna, invece, di
intrattenersi con lei non solo
come amico ma anche musicalmente,
fu Mimmo, giovanissimo anche lui
e astro nascente della musica leggera a Bagnara
(chitarra e poi tastiera). Col quale, più volte,
Mimì ebbe modo di soffermarsi. E di esibirsi,
transitoriamente, anche con “I demoni”, il
complesso di Mimmo Villari, appunto, tra i cui
componenti spiccava, per la sua splendida voce,
Raffaele Ocello (detto Jeff per via della sua
somiglianza all’attore americano Jeff Chandler),
biondo e ricciuto di capelli, e con gli occhi
chiari come lui.
Da allora, come si sa, Mimì prese il volo e, tappa
dopo tappa, alla fine, divenne quella che
tutti abbiamo conosciuto: Mia Martini, una
delle voci più intense e più belle della canzone
italiana.
Anche come Mia Martini, però, Mimì non si
scordò mai di Bagnara. Tutt’altro: il luogo natìo
le rimase sempre dentro il profondo dell’anima.
Ed era lì che spesso e volentieri lei, felicemente,
ritornava. Così come era anche lì,
quando la vita le riversava i colpi più duri, che
andava a rifugiarsi. Bagnara era, insomma, il
suo paradiso perduto, la patria dei suoi affetti
primordiali (tra cui l’amatissima zia Sarina);
della gente a portata di mano, della vita gioiosa,
libera, leggera. Bagnara per lei era il mare,
la spiaggia, gli scogli. E ancora: le vigne terrazzate,
i sentieri del castagno, i pendii di fichi
d’india. Era l’uva zibibbo e il pesce spada. Era,
insomma, tutto questo ed altro.
Ma Bagnara, per Mimì, era soprattutto il paese
delle bagnarote, queste mitiche
figure di donne-lavoratrici,
appartenenti alla classe
meno abbiente e più diffusa
della città: coffare, in casa; abili
venditrici ambulanti, fuori di
casa e, più spesso, lontano dal
paese; donne forti e intraprendenti
(conosciute, tra l’altro,
anche per il loro via-vai quotidiano
con la Sicilia per il contrabbando
del sale). E quindi:
camminatrici instancabili
(quasi sempre a piedi nudi),
divenute veri e propri mezzi di
trasporto di ogni genere di
merce. E, per questo, motore
storico dell’economia della città
fin dai tempi più lontani, e
fin quasi alle porte degli anni
Settanta.
Celebri, ad esempio, le foto
sulle bagnarote che trasportano
chili di sporte sulla testa,
del notissimo fotoreporter
Franco Pinna, negli anni Cinquanta.
Ancora più celebre la
surreale descrizione che ne fa
Stefano D’Arrigo nel suo monumentale
romanzo “Horcinus
Orca”, Mondadori 1975
(D’Arrigo, nel suo libro, le
chiama “femminote”, e Bagnara
la nomina come il “paese
delle femmine”).
Mimì era affascinata da questa straordinaria figura
femminile dalle vesti a drappi e a pieghe
greche che, più volte, da ragazzo, io mi cimentavo
a disegnare. Una sorta di amazzone calabrese,
insomma. E non perdeva mai occasione
per affermarla. Ad un intervistatore della Rai,
infatti, che una volta chiese a Mia Martini: «Se
non avessi fatto la cantante, cosa ti sarebbe piaciuto
fare?», lei, prontamente, e provocatoriamente,
rispose: «La bagnarota!». E bagnarota
Mimì, a parte i suoi evidenti tratti somatici
mediterranei, si sentì davvero tutta la vita nonostante
il suo trasferimento precoce da Bagnara
e nonostante il suo successo di cantante
nazionale e internazionale.
(Seconda parte)
Un bel ricordo di Mimì, all’indomani
della sua morte avvenuta
il 12 maggio di quindici anni
fa, ce lo da, via internet (attraverso
l’Archivio Storico-Fotografico
Bagnarese curato da
Gianni Saffioti), proprio Mimmo Villari che,
sempre tramite l’archivio, ce la fa ascoltare anche
in una inedita registrazione, alle prese con
una improvvisata, dolcissima (accompagnata
dallo stesso Mimmo alla chitarra -tastiera-) “calabrisella”;
o in un’altra eccezionale interpretazione di quella
canzone in dialetto bagnarse (Lucy) che fa: «… isativi, isativi
e curriti / curriti cu boddanza / c’aviti persu
tutta la sustanza…». E’ risaputo, infatti, che
Mia Martini abbia inciso più d’una canzone in
lingua dialettale locale.
Mimmo Villari, a parte questo ricordo a caldo
che ha mandato in internet, è restìo a parlare
dell’amicizia che lo ha legato a Mimì fin da bambini,
ed evita di pronunciarsi sulle iniziative avviatesi
(premio canoro compreso), dopo la sua
morte, nella stessa Bagnara, in nome e in ricordo
di Mia Martini. Ma qualcosa, sul sito, l’ha
messo anche per iscritto. E così veniamo a sapere
che, quando Mimì tornava a Bagnara, aveva
dei punti di riferimento ben precisi per trascorrere
le sue giornate. Oltre all’adorata zia; fuori di
casa, specie agli inizi degli anni ottanta: Radio
Perla del Tirreno, l’emittente locale fondata da
Mimmo, appunto. Ogni qual volta Mimì arrivava
in sede, è scritto, era una festa per tutti a Bagnara,
sia nei locali della Radio che fin dentro le
case della gente. Una delle cose che più la faceva
divertire, è scritto ancora, era parlare in diretta
con il pubblico che partecipava ai quiz musicali
indetti da Radio Perla e che, spesso e volentieri,
conduceva direttamente lei stessa dall’emittente.
Oppure esibirsi con “Mimmo e i Demoni”,
appunto, all’ex cinema-teatro “Italia” di Santi
Caratozzolo.
La bagnarota, dunque. Altre informazioni sul fenomeno
socio-lavorativo di questa storica figura
di donna a Bagnara le troviamo nelle continue
riproposte fatte da studiosi-amatoriali del luogo
come Tito Puntillo e lo stesso Gianni Saffioti: Bagnara,
al di fuori delle vie del mare (raccontano
i due ricercatori nei loro vari interventi), per la
sua configurazione geografica addossata alle
pendici dell’Aspromonte, non
aveva transiti agevoli, specie per
comunicare con il territorio
montano sovrastante. Fu così
che, dai tempi più addietro, le
donne di Bagnara dovettero sostituirsi
ai mezzi di locomozione,
assumendosi il gravoso
compito di fare da vettori per la
commercializzazione dei loro
prodotti, e spingendosi, per
questo, anche a distanze notevoli
dal paese. Un ruolo lavorativo,
questo del trasporto e del
commercio, che si tramandò
per secoli tra le donne di Bagnara,
e che rimase in mano loro fino
a tutto l’intero arco degli anni
Sessanta.
La descrizione delle bagnarote
e la grande ammirazione che ne
aveva Mimì di esse, la ritroviamo
nella recente pubblicazione
dedicata a Mia martini da Domenico
Gallo per l’editore Laruffa:
non è infrequente che Mimì
– scrive l’autore – parli con
ammirazione delle bagnarote
e del loro ruolo nella comunità
bagnarese, mettendo in risalto
il contributo da loro dato, in termini
di sacrificio (specie col lavoro
di ricostruzione dopo il
terribile terremoto del 1783 e
dopo, ancora, l’altro tremendo
sisma del 1908), all’economia e alla società civile
del paese. Nonché, nella monumentale monografia
della cantante, a cura di Menico Caroli,
per la Tea Edizioni. Dove, tra l’altro, si dice come,
negli anni, Mimì non perdeva occasione di
rivendicare con orgoglio il suo legame con queste
donne e con la sua terra d’origine: luogo magico
per lei, al quale si sentiva legata come «un
albero alle sue radici».
E difatti, a Bagnara Calabra, oltre a lei, era nata
anche Leda, la sorella più grande di Mimì. Così
come, lo stesso suo giorno, il 20 settembre di 3
anni più tardi, Loredana. Lì, nella casa della nonna
materna («creatura eccezionale» per Mia
Martini), dove i Bertè andavano a villeggiare ogni
estate. Solo Oliva, l’ultima delle sorelle, nacque
ad Ancona, poco tempo prima che i genitori di
Mimì, appunto, si lasciassero per sempre.
Un sussulto d’orgoglio, dunque, quello di Mia
Martini per Bagnara, una rivendicazione davvero
passionale delle sue origini. Forse in virtù anche
del fatto di voler reagire alla solitudine in
cui, più volte, era stata costretta a cedere per le
tristi vicende della sua vita. Non ultima, quella legata
all’isolamento a cui l’avevano costretta per
tanto tempo quelle assurde calunnie (dicevano
che portava iella) che, senza dubbio, per invidia,
più di qualcuno le aveva appiccicato addosso.
Cose incredibili, ridicole, ma che avevano fatto
breccia nel “meraviglioso” mondo della musica
leggera italiana. Eppure Mimì, dopo anni di silenzio,
pian piano si era rialzata da tutto e tutti.
Ed era tornata al successo come
prima, più di prima, specie
con quella splendida doppietta
di canzoni, “Almeno tu nell’universo”
(1989) e “Gli uomini non
cambiano” (1992).
Mimmo Villari, a chiusura del
suo ricordo, dalla finestra dell’Archivio
Storico Fotografico
Bagnarese, dice di lei poche e
semplici parole: «Era una ragazza
che aveva bisogno di cose
che non costano niente, aveva
bisogno di affetto, aveva bisogno
di amare e di essere amata».
Ma Mimì non fu così fortunata.
Non aveva più un uomo,
non aveva figli; da tanto tempo
non aveva più una famiglia (e
con la sorella-cantante, Loredana,
come si sa, non c’era mai
stato un gran rapporto). E anche
l’immenso amore per la
musica, per la canzone, proprio
perché troppo grande in lei, forse
non le bastò più ad un certo
punto della vita.
Una tra le più belle canzoni di
Mia Martini “Piccolo uomo” dice:
è l’ultima occasione per vivere.
Nell’omonima
biografia a lei dedicata, per
l’autore, Menico Caroli, l’ultima
occasione per vivere di Mimì
stava per essere quella del ritorno.
«Mimì – scrive Caroli – finito
il viaggio verso il successo,
stava per iniziarne un altro di
viaggi: non più di Mia Martini
però, ma di Domenica Bertè»:
un viaggio, dunque, alla ricerca
definitiva delle sue radici, della
sua Calabria, del suo paese. E
di un padre, infine, che già da
bambina, le era sempre mancato.
Nell’altra biografia, quella di
Domenico Gallo, inoltre, l’autore
ricorda ancora i ripetuti, quasi
ossessivi richiami di Mimì alle
sue origini, alle quali, con forza, lei intendeva
rimanere ancorata. E all’intervistatore che le sta
per chiedere: «Tu sei di origine calabrese…», lei
non lo lascia nemmeno finire di parlare. E con la
sua consueta provocazione, ormai; forse, addirittura,
con stizza, gli replica: «Io sono non di origine
calabrese, io sono proprio calabrese. Mia
madre è nata a Bagnara Calabra, mio padre lì vicino,
a Villa San Giovanni. Ed io sono nata a Bagnara…
più calabrese di così!». E altrove, per l’ennesima
e, purtroppo, ultima volta, Mimì ritorna
a confessare: «Le mie radici sono a Bagnara. Ho
dei parenti lì, ed io ci vado spesso laggiù: perché
le mie radici sono tutto per me, sono la mia sola
sicurezza, l’unica cosa certa della mia vita».